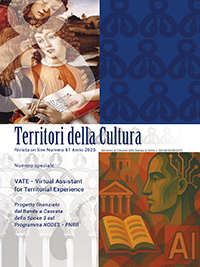Pilot project for Cultural and Creative Industries Finance, Learning, Innovation and Patenting for Cultural and Creative Industries (FLIP for CCIs-2)
Workshop: 6.2 Le lacune da colmare nelle competenze relative al patrimonio culturali
Meeting Zoom, 11 giugno 2021
Partecipanti
Stefania Monteverde, consigliera in FORM - Filarmonica Orchestra Regionale Marchigiana
Antonella Agnoli, Presidente della Fondazione Bibioteca Federiciana di Fano
Davide De Blasio, Fondatore e Presidente della Fondazione Made in Cloister (Napoli)
Monica Bernacchia, Operatrice culturale Dipartimento di Comunicazione del Museo Tattile Statale Omero, Ancona
Pierluigi Feliciati, Docente UniMc di Scienze documentarie, Coordinatore del progetto GLAM/Wiki Appennino Centro Italia
Francesco Mannino, Fondatore e Presidente di Officine Culturali
Rosaria Mencarelli, già Direttore della Rocca Albornoziana-Museo nazionale del Ducato di Spoleto.
Marco Minoja, Direttore della Direzione Cultura del Comune di Milano
Pietro Petraroja, Cofounder di CulturaValore
Silvano Straccini, Presidente Gradara Innova
Fabio Viola, Videogame Designer e Producer, Presidente di “TuoMuseo.InnovazioneCultura”
Massimiliano Zane, Consulente Strategico per la Gestione e la Valorizzazione delle Risorse Culturali del Ministero della Cultura
Programma
Il workshop rientra nell’Obiettivo Specifico 6 della Ricerca Increas: “Ricerca di esempi di buone pratiche di mappatura, test e prototipa-zione nel settore dei beni culturali”. Attraverso lo scambio di idee e di esperienze maturate in contesti diversi il focus group si è concentrato su un tema molto ampio e complesso, la questione delle competenze per la valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare su due questioni:
Questione 1: Nel contesto della pandemia da Covid19, quali limiti e criticità sono emersi nelle competenze per la valorizzazione del patrimonio cultura-le?
Questione 2: I nuovi scenari richiedono nuove competenze per la valorizzazione del patrimonio culturale: quali? Possibile individuare priorità e strategie?
Discussione
- In apertura della discussione sono stati riportati alcuni risultati della ricerca sulle competenze per il patrimonio culturale (Rapporto Finale, feb 2021) promossa dalla Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Cultural -che ha istituito un Osservatorio scientifico sui musei, secondo la quale il panorama delle professionalità nell’ambito dei beni culturali è molto variegato e soggetto a precarietà. In Italia con la Legge 110/2014 sono state introdotte nuove figure professionali, ma ancora mancano adeguati riconoscimenti normativi per le professioni museali, soprattutto le nuove legate all’innovazione. Anche la Direzione Generale dei Musei del MIC- Ministero della Cul-tura si interroga sulla necessità di definire i Livelli Uniformi di Qualità per la Valorizzazione dei Musei, e di conseguenza anche la definizione delle competenze e professionalità di un settore che in Europa è stimato pari a 3,7% dei lavoratori europei (7,4 milioni di persone nel 2019, 830.000 in Italia - Dati Eurostat).
La necessità di definire le nuove competenze si fa più urgente dopo la gran-de crisi della pandemia. Si stima (Fonte Il Sole 24 Ore, 20/05/2021 - https://www.ilsole24ore.com/art/nell-anno-covid-musei-perdono-75percento-visitatori-e-78percento-introiti-AEkEcNG) che nel 2020 i musei italiani hanno perso 4,5 milioni di visitatori, ritornando al-la situazione di venti anni fa (da 55 milioni di visitatori nel 2019 a 13 milioni nel 2020).
In questo contesto quali nuovi competenze sono necessarie per risvegliare desiderio, interesse, cura del patrimonio culturale? (SM)
- Servono più competenze nelle biblioteche. È il punto di partenza. È necessario rendere le biblioteche luoghi più affettivi e democratici: sono spazi gratuiti, accessibili a tutti, primo spazio culturale di prossimità. Più biblioteche di base e diffuse significa formare una competenza al patrimonio culturale capace di formare una società più attrezzata nei confronti dei beni culturali. Per questo occorre una formazione specifica: non bibliotecari-catalogatori ma bibliotecari-facilitatori capaci di dialogare con il tessuto sociale in cui la biblioteca è inserita. (AA)
- La valorizzazione del patrimonio culturale richiede una gestione capace di interagire con il contesto sociale in cui si trova. È quello che abbiamo fatto con la nostra impresa www.madeincloister.com : il recupero e la valorizzazione di un complesso cinquecentesco abbandonato al centro di Napoli e oggi diventato un hub culturale espositivo, performativo, laboratoriale, sociale in cui l’arte contemporanea accelera lo sviluppo, si stimola l’artigianato come portatore di valori, . Le competenze che un progetto di questo genere richiede riguardano la capacità e professionalità nuove capaci di sviluppare contenuti creativi nuovi, costruire relazioni significative con la sovrintendenza e le amministrazioni, attivare processi di fundraising. (DdB)
- L’accessibilità è una competenza trasversale necessaria per la valorizza-zione del patrimonio culturale. L’accessibilità è una direttiva europea, ma non può limitarsi solo all’accessibilità fisica al patrimonio architettonico. Occorre sviluppare competenza sull’accessibilità comunicativa in particola-re sui linguaggi innovativi. Ancora oggi siti, social, virtual tour, app, game sono totalmente privi di linguaggi comprensivi per chi è cieco o sordo. Oc-corre rafforzare le competenze sull’accessibilità digitale. Quello che facciamo con il nostro Museo Tattile Omero specializzato sull’accessibilità visiva www.museoomero.it, ma anche centro di formazione sull’accessibilità culturale con tante altre realtà museale e culturali per progettualità accessibili a tutti. (MB)
-L’unica competenza che serve è saper rendere quella esperienza culturale memorabile nella vita degli altri. Per fare questo occorre un approccio nuovo. La sfida è saper creare contenuti nativi, senza limitarci a inutili “trasferimenti digitali” per costruire “attrattori non attrattivi”. Occorre uscire dall’idea di creare prodotti per entrare nella logica della creazione di pro-cessi capaci di produrre coinvolgimento. Per questo servono competenze nuove capaci ci sviluppare empatia. Quello che facciamo con la nostra impresa innovativa specializzata nel gaming e nei linguaggi innovativi - www.tuomuseo.it (FV)
- Essenziale è la competenza nel saper creare reti. Nella formazione accademica occorre sviluppare l’attitudine a lavorare insieme, al coworking, al saper utilizzare strumenti digitali open source. L’esempio del progetto WIKI/APPENNINO per la valorizzazione della comunità patrimoniale nei territori colpiti dal sisma del 2016 attraverso processi di partecipazione attiva, raccolta-wiki di dati e informazioni, attivazione di relazioni. Servono nuove competenze anche per sviluppare nuove metriche di coinvolgimento - https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:GLAM/Wiki_Appennino_Centro_Italia (PF)
- Ho accumulato master e specializzazioni che certificano le mie competenze acquisite. Ma molte volte sono già scadute e spesso le certificazioni sono inadeguate per definire realmente il sapere fare necessario. C’è un’ansia nel definire competenze e figure professionali, ma è un processo infinito sempre in ritardo, perché la valorizzazione del patrimonio culturale ha anche fare con i tempi attuali. Ogni giorno serve empowerment delle potenzialità delle persone, capacità continua di attivare processi. Il vero problema sulla valorizzazione del patrimonio è la dignità del lavoro delle professioni culturali, non abbastanza rispettato. Quello he facciamo ogni giorno con le nostre Officine Culturali - www.officineculturali.net (FM)
- Nelle sovrintendenze c’è un problema di aggiornamento delle competenze cercando di rafforzare il legame tra tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Serve una rigenerazione culturale delle professionalità nel sistema pubblico perché gli schemi sono obsoleti. Occorre uscire dall’idea di patrimonio come bene proprietario per sviluppare una cultura di comunità. Ma questo non lo insegna nessun concorso - https://sabapchpe.beniculturali.it (RM)
- Il sistema pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale ha un compito essenziale: svolgere la funzione di ascensore sociale nei confronti delle fasce deboli della società che rischiano l’esclusione dalla fruizione e conoscenza del patrimonio culturale. Per questo fine occorre innanzitutto una competenza essenziale: saper leggere il bisogno con strumenti di ana-lisi e valutazione capaci di misurare le necessità, individuarle e quindi di attivare processi culturali significativi - https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/cultura (MM)
- La definizione delle professionalità culturali è complessa e sarebbe un errore rincorrere ancora la definizione di rigidi disciplinari delle figure professionali. I tempi sono diversi, in continuo cambiamento. Dunque, serve un sistema di formazione continua attraverso scuole di specializzazione parte al territorio e strumenti di valutazione che misuri il gradimento delle attività culturali più che il raggiungimento di obiettivi. La finalità è puntare su una competenza essenziale: valorizzare la dimensione relazionale della tutela come diritto delle persone (e non diritto dei beni culturali) e valorizzare il processo dialogico con la comunità (PP). www.culturavalore.com
- In particolare nei musei occorre una competenza nel saper dialogare con la comunità locale tutto l’anno, uscendo da meccanismi come alta stagione/bassa stagione. Per fare questo servono nuove competenze professionali, facilitatori di relazioni e processi, capaci di raccogliere memoria collettiva e rinnovarla - www.fondazionepescheria.it (SS)
- Un progettista culturale è un ruolo che ancora non è riconosciuto dal mini-stero. Eppure, è una competenza essenziale e ricercata. Ci sono professionalità e competenze richieste sulla carta che ormai sono obsolete. Facciamo una mappatura di ciò che non serve e individuiamo un professionali-tà meno specializzata e più trasversale, capace di valorizzare i cambia-menti in atto senza incasellare. L’obiettivo è definire competenze aggiornate alle esigenze attuali, profondamente modificate dopo la pandemia. E su questo costruire contratti di lavoro all’altezza di una professionalità e una managerialità culturale riconosciuta dal mercato e dai sistemi pubblici. (MZ)
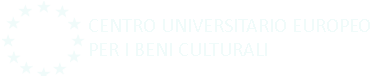
 Italian (IT)
Italian (IT)  English (UK)
English (UK)